The daughter who tranports him out of the longed-for American pastoral and into everything that is its enemy, into the fury, the violence, and the desperation of the counterpastoral: into the indigenous American berserk.
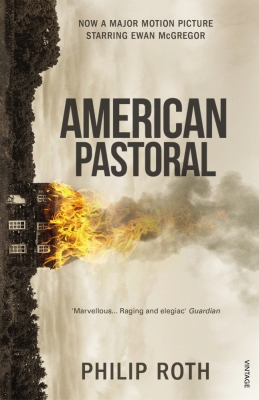 Vincenzo Mantovani traduce quell’ultima parola di Philip Roth con altre due: indigenous American berserk diventa innata rabbia cieca dell’America. Ma cos’è questo berserk che la traduzione ci ha fatto perdere?
Vincenzo Mantovani traduce quell’ultima parola di Philip Roth con altre due: indigenous American berserk diventa innata rabbia cieca dell’America. Ma cos’è questo berserk che la traduzione ci ha fatto perdere?
I berserk erano leggendari guerrieri scandinavi: leggende già nell’epoca buia e sanguinaria, o almeno così siamo soliti immaginarcela, dell’età vichinga. Ricoperti unicamente da teste pelli e artigli d’orso, di cui acquisivano così il nome e la potenza, erano i più temuti avversari sul campo di battaglia. Forse con l’aiuto di procedure sciamaniche o pozioni allucinogene i berserk precipitavano in uno stato di selvaggio invasamento: mordevano i loro stessi scudi, dalla bocca schiumante uscivano urla belluine, dai muscoli irrigiditi delle braccia partivano furiosi fendenti. Instancabili, insensibili, inarrestabili. Il loro obiettivo non era combattere con onore, non era neppure vincere, non era rimanere in vita per godersi i festeggiamenti nelle grandi sale di legno, non temevano la morte. Il loro unico scopo era squartare, spezzare, trafiggere, ricoprire il mondo di porpora, finché ogni forza li avrebbe abbandonati, lasciandoli indifesi e sprofondati nel sonno per giorni e giorni.
Il berserk della nostra storia non è Lo Svedese, lui è il nostro protagonista: Seymour Lvov ebreo di Newark, alto e biondo, intelligente e atletico, dotato negli sport come negli affari. Ammirato da tutta la popolazione israelitica del sobborgo perché rappresenta l’incarnazione stessa del sogno americano, figlio marito e padre fedele, la descrizione della sua vita è un’iscrizione sulla lapide. Uomo giusto e buono, fa sempre, la cosa migliore per tutti. Non lo guida l’ambizione o la bramosia, ma il rispetto per il padre, l’amore per la famiglia, per un guanto ben fatto, ama il sogno americano perché lui stesso ne è la più alta e vera realizzazione. Nessun rimpianto, nessun dubbio, nessun segreto, nessuna sofferenza esistenziale somatizzata nell’alcool. Lo Svedese non è Gatsby. Lo Svedese è felice di essere se stesso.
Il berserk della nostra storia è Merry, la figlia dello Svedese. Nonostante il nome non porterà a lungo felicità alla famiglia Lvov. Bambina balbettante prima, adolescente rabbiosa poi, è fonte di preoccupazione per i genitori, che cercano di aiutarla in ogni maniera possibile, forti del loro amore e delle loro risorse. Ma nulla serve a lungo per lei, ha scelto la sua strada e nulla può fermarla perché non ci sono argomentazioni razionali dietro ciò che muove lei nella lotta sempre più violenta contro la guerra in Vietnam. Dentro di lei si cela il caos, l’anarchia selvaggia, il desiderio di vedere crollare tutto, fare esplodere la perfezione della sua famiglia in miliardi di coriandoli colorati. Saranno le esplosioni infatti a coronare la ribellione totale di una sedicenne sovrappeso, tra le grida e la bocca balbuziente ricoperta di saliva. Lasciando il padre ad affrontare per la prima volta in vita sua l’orrore e il disgusto, ma soprattutto il dubbio e l’esitazione, un germe che presto infetta tutto il piccolo paradiso della vita dello Svedese.
Ancora una volta sono i personaggi, grandiosi, tragici, profondamente umani e veri, che siano protagonisti o accessori narrativi, l’arma segreta di Roth. Come per i grandi russi, di cui lo scrittore stesso non fa mistero essere un gran ricopiatore, gli umani che si agitano sulla carta sono personalità vaste e profonde, la cui esplorazione supera quella della trama, che alla fine segue sempre quello schema di peripezia arcaico e fisso e che emerge facilmente grattando la superficie moderna e nichilista del romanzo. Come il Roth di Nemesi, come l’altro Roth, quello che invece nel sogno americano aveva creduto, tutti gli ebrei del mondo, che sono solo un modo per dire quelle persone che meditano troppo a lungo sul significato delle cose fino a rompersi la testa, Pastorale Americana è di nuovo il libro di Giobbe, solo senza Yawhe a cui inviare le lamentazioni. Senza nessuno che ascolti la domanda, siamo noi gli unici interlocutori, a cui viene chiesto di capire perché basti una scheggia impazzita, un microscopico virus, un battito di farfalla, a far crollare il nostro castello. I suoi personaggi passano le loro brevi esistenze a cercare di capire cosa ha causato la loro rovina, se la colpa è delle fondamenta o della forza del cancro alla prostata, della ricchezza o della povertà, del capitalismo o del socialismo, del troppo amore o del poco amore, dell’integrazione multiculturale o dell’integralismo islamico. Philip Roth passa un’intera vita a gridare ai suoi smarriti personaggi che non possono sentirlo: nessuno ne ha colpa! Nessuno! Con un gesto che sembra di clemenza costruisce una cornice, ci fa sperare che la storia non sia andata davvero così, che sia un artificio letterario di Zuckerman, ma la cornice regge solo metà del quadro e l’abisso che spalanca oltre i suoi confini è colmo delle potenze del caos, che danzano sbavanti di sangue terra e saliva, coperte da pelli d’orso. Mentre le sue domande riverberano nel vuoto, scuotendo ogni certezza.















