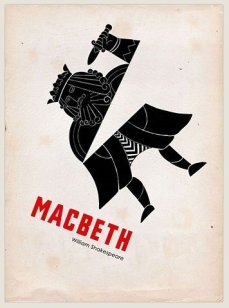 Da dietro una quinta osservo teso i miei compagni di classe. Sul palco una tredicenne vestita di bianco sfrega le mani cercando di rimuovere macchie immaginarie e nel sonno lancia grida tormentate che fanno rabbrividire il pubblico e noi, oltre le pesanti tende. Tra poco tocca a me, altro mondo, altro tempo, altre strida, prima di tornare nella Scozia dell’Anno Mille o su un treno che viaggia verso una meta sconosciuta, nella Sicilia degli anni venti o in un paesaggio ucronico e assurdo. Di nuovo Scozia, di nuovo Medioevo. Alle ragazze più carine toccava la parte delle streghe, ovviamente, per un Macbeth smarrito e disperato, ipnotizzato come noi dalla ridda in rima.
Da dietro una quinta osservo teso i miei compagni di classe. Sul palco una tredicenne vestita di bianco sfrega le mani cercando di rimuovere macchie immaginarie e nel sonno lancia grida tormentate che fanno rabbrividire il pubblico e noi, oltre le pesanti tende. Tra poco tocca a me, altro mondo, altro tempo, altre strida, prima di tornare nella Scozia dell’Anno Mille o su un treno che viaggia verso una meta sconosciuta, nella Sicilia degli anni venti o in un paesaggio ucronico e assurdo. Di nuovo Scozia, di nuovo Medioevo. Alle ragazze più carine toccava la parte delle streghe, ovviamente, per un Macbeth smarrito e disperato, ipnotizzato come noi dalla ridda in rima.
Fair is foul, and foul is fair.
Hover through the fog and filthy air
È tremendamente difficile accostarsi a Shakespeare. All’enorme peso che le sue opere hanno avuto e continuano ad avere nella storia della letteratura e dell’arte mondiale, corrisponde una opposta e irriducibile sfuggevolezza della materia su cui si basa questa fama. Drammi incompleti, ricopiati, interpolati, ricuciti e tradotti, in prosa e in altre lingue, raccolti per essere letti o recitati ad alta voce, in teatro in mezzo ai popolani che si accoppiano sulle gradinate o di fronte al re nei suoi appartamenti privati. Opere che parlano di sogni, di incubi, fantasmi e visioni. Nebbia e illusione affollano il teatro del Bardo. Il regista poi, ogni volta, e con lui gli attori, interpretano, inventano, tagliano e aggiungono, ogni volta una cosa nuova eppure così antica. Nel 1936 Orson Welles, prima del film, ne curò una versione teatrale, nota come Voodoo Macbeth. Gli attori erano neri e invece che in Scozia il dramma era ambientato ad Haiti. Nei buchi della trama i lettori del copione riversano pulsioni sessuali inespresse, maternità interrotte, allusioni politiche, teologiche. A causa della straordinaria densità semantica riversata in ogni verso, una singola parola detta o solo immaginata, può cambiare il senso a tutta l’opera. How tender’tis to love the babe that milks me Da dieci anni però, ho ancora in mente le grida dell’attrice, e le esitazioni dell’attore che impersonavano Macbeth e la sua sposa. Mentre molto altro è già scivolato via, a raggiungere tutta l’altra materia di cui sono fatti i ricordi, loro li vedo ancora.
Out, damned spot! Out, I say!
Facciamo allora una cosa vietatissima. Togliamo, uno alla volta tutti i personaggi di contorno. I Thane di di Scozia e i soldati inglesi, Macduff e famiglia, medici e dame di compagnia, servitori e vedette, togliamo il portiere ubriaco che fa battute sull’erezione, togliamo persino le streghe, le sorelle fatali che predicono il futuro di Macbeth, e con loro tutti gli spiriti, la nebbia, i tuoni e i fulmini i corvi i gufi i terremoti che sconquassano la notte sulla brughiera e che tanto danno all’atmosfera dell’opera. Cosa resta? Loro due, marito e moglie. Per nessun altro motivo apparente che non sia la propria ambizione, decidono di uccidere il re, un buon re. Per tutto il resto del dramma dovranno affrontare le conseguenze del loro atto scellerato. Non c’è onore, amore, vendetta, inganno, giustizia, cecità, che possa sostenere il loro incedere tragico. Edipo almeno era cieco. Amleto adirato. Otello geloso. Loro hanno solo l’altro a sostenerli. È la loro solitudine a renderli così grandi. Come Faust hanno venduto la loro anima alle potenze infernali, ma invece che ricchezze e onori, ne hanno ottenuto solo sofferenze, soli con le proprie scelte, insicurezze, dubbi, paure e rimpianti consapevoli di essere nel torto, di fare il male. Entrambi dovranno indurire il proprio cuore, o perire.
I have almost forgot the taste of fear.
Il sangue scorre a fiumi e impregna vestiti e anime. Ma i personaggi magnanimi si innalzano comunque in questo mare arrossato, nonostante il peso del manto reale sia troppo per loro. Macbeth è una tragedia di sapore quasi cattolico, che parla di libero arbitrio a un mondo Riformato, dove si è soli di fronte a Dio e al suo disegno incomprensibile ma pur sempre liberi di ribellarvisi. Rimettiamo quindi al loro posto tutti gli altri personaggi, che hanno importanza anche loro: streghe bitorzolute e buoni sudditi. Ritiriamoci dietro le quinte a guardare gli attori che strepitano sul palco una storia che non sembra avere molto senso. Prepariamoci perché i prossimi a salire siamo noi.
Questo libro è stato letto in occasione della #maratonashakesperiana organizzata da Scratchbook su Facebook. Per partecipare guarda QUI.


 Primo Levi racconta, in un intervista, che uno dei suoi più grandi rimpianti fu quello di non aver viaggiato. Dopo tutto quello che gli era successo c’erano così tante cose da fare: il matrimonio, la famiglia da mantenere, il lavoro di chimico, la fabbrica da dirigere, i figli da mandare a scuola, la vita normale insomma. Per la fabbrica di vernici andò in Germania e in Russia, a risolvere i problemi dei clienti, ma non era esattamente quello che intendeva per viaggiare. C’era stato un periodo della sua vita, così piacevolmente lontano da qualsiasi concetto di viaggio organizzato, che ricordava sempre con piacere, che riempiva le serate con gli amici e poteva raccontare senza timore di rattristare o disgustare i suoi ascoltatori. Subito dopo essere stato liberato dalla prigionia Levi fu infatti sballottato lungo tutta l’Europa dell’Est per mesi, senza una meta o un posto definitivo dove fermarsi che non fosse un Italia vagheggiata e lontana come l’Itaca di Ulisse. Seguendo binari sincopati e interminabili percorsi a piedi tra pianure boschi e paludi di Polonia e Bielorussia Levi aveva seguito il percorso casuale e caotico dell’Armata Rossa in smobilitazione, epico organismo multicefalo governato solo dall’ordine supremo di rientro e dalla voglia infinita di tornare nelle proprie case, in treno, a cavallo, a piedi o su taxi e pulmann saccheggiati nella Germania nazista.
Primo Levi racconta, in un intervista, che uno dei suoi più grandi rimpianti fu quello di non aver viaggiato. Dopo tutto quello che gli era successo c’erano così tante cose da fare: il matrimonio, la famiglia da mantenere, il lavoro di chimico, la fabbrica da dirigere, i figli da mandare a scuola, la vita normale insomma. Per la fabbrica di vernici andò in Germania e in Russia, a risolvere i problemi dei clienti, ma non era esattamente quello che intendeva per viaggiare. C’era stato un periodo della sua vita, così piacevolmente lontano da qualsiasi concetto di viaggio organizzato, che ricordava sempre con piacere, che riempiva le serate con gli amici e poteva raccontare senza timore di rattristare o disgustare i suoi ascoltatori. Subito dopo essere stato liberato dalla prigionia Levi fu infatti sballottato lungo tutta l’Europa dell’Est per mesi, senza una meta o un posto definitivo dove fermarsi che non fosse un Italia vagheggiata e lontana come l’Itaca di Ulisse. Seguendo binari sincopati e interminabili percorsi a piedi tra pianure boschi e paludi di Polonia e Bielorussia Levi aveva seguito il percorso casuale e caotico dell’Armata Rossa in smobilitazione, epico organismo multicefalo governato solo dall’ordine supremo di rientro e dalla voglia infinita di tornare nelle proprie case, in treno, a cavallo, a piedi o su taxi e pulmann saccheggiati nella Germania nazista.






















