È capitato sicuramente anche a voi, aspettando il treno la metro o la corriera, di spegnere provvisoriamente il cervello. Dopo una lunga giornata o appena svegli, in attesa alla stazione lo sguardo si fissa sulla banchina opposta, il vociare vicino diventa sempre più indistinto, pensieri e preoccupazioni che ci accompagnano fedeli in ogni altro momento di calma della giornata che svaporano indistinti. E poi eccolo che arriva: il velocissimo mezzo metallico che scorre a un palmo di naso. Le finestre, rintoccano ritmicamente ipnotiche. Allora, in quel preciso momento, prima che il treno si fermi e le porte si aprano, ci si avvicina a ciò che raccontano sciamani e asceti da millenni: la divisione della coscienza dal corpo. Non sarebbe infatti possibile, lasciandosi andare, concentrando l’attenzione su quel luogo così distante nel nostro cervello, farlo veramente? Anche se stiamo solo aspettando che il treno si fermi? E provare così ad immaginare quello che accadde a Darrel Standing nel romanzo di romanzi scritto da Jack London: Il vagabondo delle stelle.
Siamo nella California di inizio novecento, un posto tutt’altro che civile. Niente bionde abbronzate che surfano, per ora. Standing, professore di agronomia, è stato condannato per omicidio all’ergastolo. Per una serie di malversazioni viene costretto in cella d’isolamento, pena spesso e volentieri accompagnata dall’uso sfrenato della camicia di forza. In questa situazione estrema conosce gli altri inquilini del braccio d’isolamento: Ed Morrel e Jake Oppenheimer, con i quali comincia a comunicare attraverso un codice segreto che camuffa quello Morse. Quindi, grazie ai consigli dei due compagni di sventura, riesce ad autoindursi una condizione di sospensione spirituale per sopravvivere alle torture dei suoi carcerieri. Il grosso problema è che il nostro eroe comincia a prenderci gusto: scopre infatti che portando ogni volta un po’ più in la la soglia della sua morte-in-vita riesce a rivivere esistenze precedenti sedimentate nella sua coscienza da migliaia di anni, vite e vite, in luoghi epoche e corpi incredibilmente distanti tra loro.
Eccoci giunti infine al cuore del libro: una serie di racconti d’avventura che rispettano quasi maniacalmente le casistiche narrative avventurose più classiche. C’è il romanzo di costume medievale, il romanzo di sventure marinaresche (anzi due), il romanzo storico che attinge all’epopea western come Lo studio in rosso di Conan Doyle, il romanzo di avventure esotiche. Tutti perfetti e autentici episodi narrativi in perfetto stile londoniano. Oppure coloratissimi kolossal hollywoodiani anni ’50. Non sarebbe azzardato pensare che alcuni racconti siano stati scritti da soli per poi essere incasellati nella splendida cornice che London aveva preparato. Un racconto di racconti, tra i più classici, dalle Mille e una notte al Decamerone. Qualcosa che mai nessuno prima di lui avesse tentato, scrisse London al suo editore.
E forse è vero. Perché quella che fino ad ora è sembrato solo un banale pretesto per pubblicare un blocco di racconti assieme per recuperare i soldi necessari a mantenere il Beauty Ranch a Sonoma County e i suoi numerosi abitanti, si espande, penetrando negli interstizi tra le avventure metempsichiche di Darrel Standing. Con il peculiare stile che appartiene solo a lui, a cavallo tra i secoli ed eternamente oscillante tra circonvoluzioni metafisiche e periodi sbozzati con l’ascia, cinico e razzista quanto sensibile e curioso delle culture più lontane, attento studioso di storia e filosofia e colossale mistificatore; London, questo ossimoro vivente, rimpinza il libro di filosofia orientale e di attente critiche storiche e sociali, di verità e verosimiglianza, tornando alla più profonda essenza del romanzesco. È vero, basato su dettagliatissime ricostruzioni, il massacro dei pionieri nel deserto salato dello Utah. Sono veri i personaggi di Oppenheimer e Morrel, vere le torture a cui venivano sottoposti i prigionieri nel paese più democratico del mondo, nella California del sogno americano.
Come è possibile conciliare l’eterno ritorno dell’uguale e l’inevitabile spinta progressiva dell’essere umano per il miglioramento proprio e della società? Due pensieri così lontani e distinti come il giorno e la notte: come possono stare nello stesso libro, nella stessa mente? Come può il socialista Jack London, che lotta per i diritti civili, esaltare la forza il coraggio e l’intelligenza dell’uomo ariano attraverso le ere? Con un racconto, il più facile ed economico mezzo di viaggio dell’anima conosciuto. Ed Morrel, quello vero, condannato all’ergastolo per aver fatto parte di una banda di banditi ferroviari un po’ anticapitalisti, fu graziato in seguito al successo del Vagabondo delle stelle. Darrel Standing invece, condannato alla sua esistenza di eroe fittizio, continua e continuerà a morire e rinascere, morire e rinascere per l’eternità, dalla prima all’ultima pagina nell’eterno ritorno della prigione in cui è stato rinchiuso.
…
Centrale, stazione di Centrale, lasciare scendere i passeggeri prima di salire.
…
Bonus:












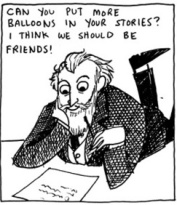

 Un giovane ragazzo, figlio di un avvocato della provincia francese, tentò una volta di scappare di casa per imbarcarsi su una nave mercantile. Come Gordon Pym prima, come Conrad dopo. Lo spirito del mare lo chiamava, quello spirito che ti prende allo stesso modo tra le pagine dei libri e sulle scogliere di fronte alle onde. Scappò di notte dalla grande casa calda per vedere luoghi che conosceva solo di nome. Corruppe il capitano per farsi imbarcare, preparò con cura il suo bagaglio, pronto ad abbandonare per sempre il paese dove era nato. Il padre lo ripescò adirato qualche giorno dopo, in un porto poco distante. Non provò più a scappare di casa. Cercò quell’avventura che tanto bramava tra le pagine asciutte dei libri, studiò e si laureò in Lettere e cominciò a scrivere poesie. Ma il padre non condivideva, lo ripescò di nuovo dai suoi libri e lo costrinse a concludere gli studi di Legge. E lui obbedì. Come sempre. Divenne agente di cambio, si sposò con una donna facoltosa e si avviò a trascorrere una tranquilla esistenza borghese nel paese più borghese del mondo.
Un giovane ragazzo, figlio di un avvocato della provincia francese, tentò una volta di scappare di casa per imbarcarsi su una nave mercantile. Come Gordon Pym prima, come Conrad dopo. Lo spirito del mare lo chiamava, quello spirito che ti prende allo stesso modo tra le pagine dei libri e sulle scogliere di fronte alle onde. Scappò di notte dalla grande casa calda per vedere luoghi che conosceva solo di nome. Corruppe il capitano per farsi imbarcare, preparò con cura il suo bagaglio, pronto ad abbandonare per sempre il paese dove era nato. Il padre lo ripescò adirato qualche giorno dopo, in un porto poco distante. Non provò più a scappare di casa. Cercò quell’avventura che tanto bramava tra le pagine asciutte dei libri, studiò e si laureò in Lettere e cominciò a scrivere poesie. Ma il padre non condivideva, lo ripescò di nuovo dai suoi libri e lo costrinse a concludere gli studi di Legge. E lui obbedì. Come sempre. Divenne agente di cambio, si sposò con una donna facoltosa e si avviò a trascorrere una tranquilla esistenza borghese nel paese più borghese del mondo.

 Ci sono libri che, una volta venuti alla luce, si depositano silenziosi sugli scaffali delle biblioteche o sulle mensole di qualche possessore di libri particolarmente stramboide. Al buio. Una breve esistenza negli scaffali delle novità e poi basta, nessuna ristampa, nessun seguito. Il nulla. Un fallimento editoriale. Dobbiamo dispiacerci forse per il loro destino d’oblio? E rimproverare la casa editrice o l’addetto al marketing di aver permesso al libro di scomparire? Era un libro brutto? È possibile invece che per qualche misterioso motivo i libri accecati dalla luce troppo sfolgorante della ribalta decidano motu proprio di ritirarsi dalla vista. Piano piano, anno dopo anno, secolo dopo secolo, questi libri non si trovano più sulle liste, le loro pagine web diventano obsolete, scivolano piano piano grazie alle mani di un’inconsapevole commesso dallo scaffale delle novità a quello di un genere che non è il loro, al magazzino, al macero. È timidezza? O speranza di una gloria più grande in futuro? Forse attendono con trepidazione che un archeologo librario entri nel loro antro polveroso e li renda grandi, più grandi di quanto avessero sperato.
Ci sono libri che, una volta venuti alla luce, si depositano silenziosi sugli scaffali delle biblioteche o sulle mensole di qualche possessore di libri particolarmente stramboide. Al buio. Una breve esistenza negli scaffali delle novità e poi basta, nessuna ristampa, nessun seguito. Il nulla. Un fallimento editoriale. Dobbiamo dispiacerci forse per il loro destino d’oblio? E rimproverare la casa editrice o l’addetto al marketing di aver permesso al libro di scomparire? Era un libro brutto? È possibile invece che per qualche misterioso motivo i libri accecati dalla luce troppo sfolgorante della ribalta decidano motu proprio di ritirarsi dalla vista. Piano piano, anno dopo anno, secolo dopo secolo, questi libri non si trovano più sulle liste, le loro pagine web diventano obsolete, scivolano piano piano grazie alle mani di un’inconsapevole commesso dallo scaffale delle novità a quello di un genere che non è il loro, al magazzino, al macero. È timidezza? O speranza di una gloria più grande in futuro? Forse attendono con trepidazione che un archeologo librario entri nel loro antro polveroso e li renda grandi, più grandi di quanto avessero sperato.












