 Sono qui nella lavanderia, il famoso luogo mistico che favorisce la meditazione e la riflessione. Le lavatrici ruotano silenziose risciacquando gli stracci sporchi. Dalle grate esterne sale una densa nuvola di vapori che viene su dagli scarichi delle asciugatrici, dalle bocche incorniciate di granito di una vecchia cantina o carbonaia. La nebbia isola il piccolo locale dal mondo esterno, che irrompe comunque ogni volta che un cliente entra accompagnato dal fragoroso scampanellio sovrastando il rifrangersi della biancheria nella centrifuga che fa
Sono qui nella lavanderia, il famoso luogo mistico che favorisce la meditazione e la riflessione. Le lavatrici ruotano silenziose risciacquando gli stracci sporchi. Dalle grate esterne sale una densa nuvola di vapori che viene su dagli scarichi delle asciugatrici, dalle bocche incorniciate di granito di una vecchia cantina o carbonaia. La nebbia isola il piccolo locale dal mondo esterno, che irrompe comunque ogni volta che un cliente entra accompagnato dal fragoroso scampanellio sovrastando il rifrangersi della biancheria nella centrifuga che fa
.
wush
wush
BUONGIORNO! COME ANDIAMO!? SANTINI GIUSTO? È QUI TUTTO PRONTO SA PERO’ QUEL COLLO LI PIU’ DI TANTO NON SI PUO’ FARE ARRIVEDERCI ME LO SALUTI TANTO!
wush
Nonostante la lavanderia sia automatica i padroni sono sempre lì. Attivissimi sorridono aiutano puliscono stirano cambiano ridono salutano compatiscono consigliano matronali. Perfetto esempio di una piccolissima borghesia brianzola che aveva dei locali sfitti e si irritava a sentire il capitale immobilizzato, nonostante sul tavolinetto davanti alle poltroncine ci siano Internazionale e L’Espresso (adesso c’è anche il Dipiù che sennò la clientela fascia vecchia signora non ha niente da leggere). Per fortuna non è come la piccolissima borghesia francese, che è quasi un tòpos tutto d’oltralpe, vedove raggrinzite che risparmiano centesimo su centesimo ritirandosi dalla propria vita e prosciugando quella degli altri, che apprezzano libri fastidiosi come la Dama delle Camelie, dove si parla c o s t a n t e m e n t e di soldi, che tanto lei alla fine crepa e il capitale resta intatto. Come i personaggi sudici e squallidi incontrati da Cèline nei suoi vagabondaggi o quelli raccontati spesso dall’abile penna di Georges Simenon. Come i Pitard, schiatta di questo tipo, che da il nome a un breve romanzo del suddetto famoso autore di libri gialli.
C’è un capitano coraggioso di nome Emile Lannec, che dopo aver servito sulle navi degli altri invece dei lupini si compra la nave tutta. C’è la moglie, che si ostina a seguirlo nel suo primo viaggio da capitano e proprietario, per tutelare gli interessi di famiglia, che ha fatto da garante per il naviglio. Eh si, perché la famiglia, i Pitard, sono tutta una cosa sola fatta di zie e figli ignavi e nipoti disabili che si muove quasi come un organismo unico e teme che anche un matrimonio possa danneggiare la stabilità finanziaria dei risparmi messi da parte con tanta sofferenza e tanto godimento. I Lannec invece non sono così, no, o meglio lui non è così. È un capitano del Mare del Nord, dove le onde sono più alte dei condomini posseduti dai Pitard e dove ogni giorno può essere l’ultimo e devi dare tutto te stesso per salvare la barca, gli uomini, la vita. Tra i flutti potenti del “polmone marino” che fonde aria e acqua in un unica sostanza, si scontrano entità superiori alle volontà delle singole persone, capaci di scuotere anche i sentimenti più profondi. Il sospetto e l’inganno si nascondono tra mezze frasi e biglietti anonimi.
Simenon scrive breve e conciso, come solo lui sa fare e quindi non vedo perché io debba dilungarmi più di tanto a raccontarvi delle grosse mani di Emile o della figura efebica ma rigida di Mathilde e della loro sfida tra le onde del mare in tempesta, della miseria e della follia umana. Un libro che si legge in pochissimo tempo, per rilassarsi da letture più impegnative, ma con la forza potente di una tragedia, dipinta coi colori scuri e grigi del Nord. Solo che non ci sono grandi eroi e tutto quanto, nell’Atlantico, sembra ancora più piccolo e misero.
Fuori piove lentamente una pioggia oleosa, il cielo è grigio mentre il sole tramonta. Tutte le lenzuola sono asciutte, si torna a casa. Il campanello strilla mentre esco attraverso la nebbia.







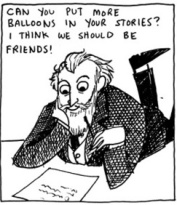


 Un giovane ragazzo, figlio di un avvocato della provincia francese, tentò una volta di scappare di casa per imbarcarsi su una nave mercantile. Come Gordon Pym prima, come Conrad dopo. Lo spirito del mare lo chiamava, quello spirito che ti prende allo stesso modo tra le pagine dei libri e sulle scogliere di fronte alle onde. Scappò di notte dalla grande casa calda per vedere luoghi che conosceva solo di nome. Corruppe il capitano per farsi imbarcare, preparò con cura il suo bagaglio, pronto ad abbandonare per sempre il paese dove era nato. Il padre lo ripescò adirato qualche giorno dopo, in un porto poco distante. Non provò più a scappare di casa. Cercò quell’avventura che tanto bramava tra le pagine asciutte dei libri, studiò e si laureò in Lettere e cominciò a scrivere poesie. Ma il padre non condivideva, lo ripescò di nuovo dai suoi libri e lo costrinse a concludere gli studi di Legge. E lui obbedì. Come sempre. Divenne agente di cambio, si sposò con una donna facoltosa e si avviò a trascorrere una tranquilla esistenza borghese nel paese più borghese del mondo.
Un giovane ragazzo, figlio di un avvocato della provincia francese, tentò una volta di scappare di casa per imbarcarsi su una nave mercantile. Come Gordon Pym prima, come Conrad dopo. Lo spirito del mare lo chiamava, quello spirito che ti prende allo stesso modo tra le pagine dei libri e sulle scogliere di fronte alle onde. Scappò di notte dalla grande casa calda per vedere luoghi che conosceva solo di nome. Corruppe il capitano per farsi imbarcare, preparò con cura il suo bagaglio, pronto ad abbandonare per sempre il paese dove era nato. Il padre lo ripescò adirato qualche giorno dopo, in un porto poco distante. Non provò più a scappare di casa. Cercò quell’avventura che tanto bramava tra le pagine asciutte dei libri, studiò e si laureò in Lettere e cominciò a scrivere poesie. Ma il padre non condivideva, lo ripescò di nuovo dai suoi libri e lo costrinse a concludere gli studi di Legge. E lui obbedì. Come sempre. Divenne agente di cambio, si sposò con una donna facoltosa e si avviò a trascorrere una tranquilla esistenza borghese nel paese più borghese del mondo.
 L‘isola di Montecristo è l’isola più solinga dell’Arcipelago Toscano. Spoglia e rocciosa, ha resistito a innumerevoli tentativi di colonizzazione, nemmeno gli eremiti riuscivano a restarci a lungo. Una leggenda raccontava che un tesoro immenso fosse nascosto sotto l’altare della chiesetta di S.Mamiliano: ebbene è stato trovato recentemente, in una chiesa dedicata a S.Mamiliano, ma sulla terraferma. Per fortuna il tesoro è stato trovato pochi anni fa perché altrimenti, per qualche strano caso del destino, non avremmo mai avuto Il Conte di Montecristo (Feltrinelli, pp. 1066, euro 15).
L‘isola di Montecristo è l’isola più solinga dell’Arcipelago Toscano. Spoglia e rocciosa, ha resistito a innumerevoli tentativi di colonizzazione, nemmeno gli eremiti riuscivano a restarci a lungo. Una leggenda raccontava che un tesoro immenso fosse nascosto sotto l’altare della chiesetta di S.Mamiliano: ebbene è stato trovato recentemente, in una chiesa dedicata a S.Mamiliano, ma sulla terraferma. Per fortuna il tesoro è stato trovato pochi anni fa perché altrimenti, per qualche strano caso del destino, non avremmo mai avuto Il Conte di Montecristo (Feltrinelli, pp. 1066, euro 15). 













