Gli escapisti sono quegli illusionisti, maghi, prestigiatori, artisti (chiamateli come volete) che intrattengono il pubblico con mirabolanti fughe ed evasioni dalle più disparate situazioni costrittive. Legati con una corda piedi e polsi, incatenati o ammanettati, chiusi in baule o in sacco, dentro una cassa o in una teca di vetro riempita di acqua, oppure molto più spesso tutte queste cose assieme, gli escapisti devono liberarsi nel minor tempo possibile, a maggior godimento del pubblico pagante. Purtroppo, accompagnati già per molto tempo da una fama non molto lusinghiera, i maghi (chiamiamoli con il loro nome) anche questa volta sono dovuti correre ai ripari. La disciplina che studiano gli escapisti infatti non è l’escapismo, ma l’escapologia, inamidatissimo sostantivo sicuramente scelto dalla comunità scientifica internazionale per evitare a un mestiere, frutto di anni di pratica ed esercizio, l’accostamento con pratiche ritenute grandemente disdicevoli. L’escapista infatti, nonostante la liberazione finale sia sempre legata ad un trucco, deve confrontarsi con ambienti angusti, costrizioni varie, apnee, lucchetti, ed è inaccettabile che fantasie di fuga dalla dura realtà vengano confuse con un mestiere che affronta il gelo del ferro sulla nuda pelle e interminabili ore di esercizi ginnici preparatori.
Noi però rifuggiamo da sterili eufemismi. Cos’è meglio? Escapologo od escapista? Non sembra anche anche a voi che il primo ricordi troppo da vicino parole come podologo e proctologo? A quella laringale che chiude la voce, non preferite il lungo sibilo che sfugge tra i denti di escapisssssssssta?
Joseph K. vive a Praga ed è ebreo. All’improvviso si trova invischiato in una situazione particolarmente spiacevole. Un potere superiore ed oscuro comincia ad accusarlo di qualcosa di indefinito, senza che lui possa fare niente per impedirlo o per difendersi, intrappolato fin da subito nelle pastoie di una burocrazia tra le più raffinate mai comparse sulla Terra. Combattere un potere tanto grande è fuori discussione e anche la fuga, più il tempo passa, più diventa impossibile. Ma non vorrei portarvi fuori strada, la K. sta per Kavalier, e siamo già alla fine degli anni trenta. Il potere è nelle mani del partito nazionalsocialista tedesco anche in quella che fu la Repubblica Cecoslovacca, e i nazisti non sono abituati a fare processi, prima di esprimere una condanna. Grazie all’aiuto di un vecchio maestro prestigiatore, ai suoi genitori e a un’incalcolabile dose di fortuna, il giovane Kavalier riesce a raggiungere la terra delle opportunità, l’America. Qui, insieme al cugino Clayman inventerà l’Escapista (guarda guarda), il più grande supereroe dei fumetti dopo Superman e Batman. Questa è la storia, e non vi dirò niente più di quello che succede, perché ogni cosa in questo libro, trama e sofferenze comprese, è stata pensata per intrattenere e deliziare il lettore. Con una maestria indubbia, Micheal Chabon padroneggia i ferri del mestiere, grimaldelli e cappelli con il doppio fondo, al punto che l’unica cosa che riesco a dirvi è: state seduti e godetevi lo spettacolo.
Dopo aver dato forma e spessore ai due protagonisti de Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay, gli fa fare esattamente quanto promesso nel titolo: formidabili avventure, fortune e sventure, coincidenze e ritrovamenti. Chi crede che un romanzo debba essere realistico cercherà inutilmente, ma in fin dei conti, quale racconto lo è veramente? E poi a volte la vita è anche più assurda dell’invenzione. Attraverso la New York scintillante e ricolma di opportunità di prima della guerra, distese di ghiaccio perenne, o gli sconfinati labirinti segreti che si nascondono sotto all’Empire State Building i due personaggi crescono, imparano, perdono, e noi trepidiamo con loro, seguiti da uno sguardo familiare e onniscente, che ci svela il futuro mentre ci inganna sul presente, porta a spasso la nostra attenzione con rapidi movimenti delle dita, mentre il trucco è predisposto dentro la cassa fin dal giorno prima. Per ottocento pagine fuggirete da questo mondo, in un altro chiuso e confortevole, che profuma di assi di pino e fango della Moldova o che puzza di sigarette e adolescenti sudati, ma non per questo immune da scossoni e cadute. Nessuno è mai troppo lontano dalla violenza del mondo, nemmeno in quello della fantasia.
Micheal Chabon ha scritto questo libro riversandovi la sua passione per i fumetti e la loro Età dell’Oro, per la magia del grande Houdini, grazie alle sue origini ebraiche e al suo essere altrettanto americano, ma l’ha scritto per deliziare il lettore. Il quale, pur sapendo che tutto è un trucco, tutto è falso invenzione illusione magia prestidigitazione, si siederà di fronte al palco, nell’attesa del miracolo. Per quanto abili siano nella fuga, i maghi ricompaiono sempre per l’applauso.
.
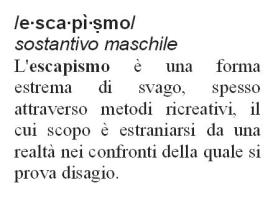

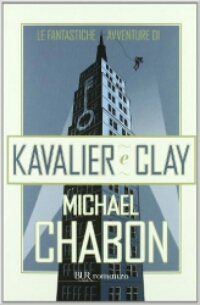

 Primo Levi racconta, in un intervista, che uno dei suoi più grandi rimpianti fu quello di non aver viaggiato. Dopo tutto quello che gli era successo c’erano così tante cose da fare: il matrimonio, la famiglia da mantenere, il lavoro di chimico, la fabbrica da dirigere, i figli da mandare a scuola, la vita normale insomma. Per la fabbrica di vernici andò in Germania e in Russia, a risolvere i problemi dei clienti, ma non era esattamente quello che intendeva per viaggiare. C’era stato un periodo della sua vita, così piacevolmente lontano da qualsiasi concetto di viaggio organizzato, che ricordava sempre con piacere, che riempiva le serate con gli amici e poteva raccontare senza timore di rattristare o disgustare i suoi ascoltatori. Subito dopo essere stato liberato dalla prigionia Levi fu infatti sballottato lungo tutta l’Europa dell’Est per mesi, senza una meta o un posto definitivo dove fermarsi che non fosse un Italia vagheggiata e lontana come l’Itaca di Ulisse. Seguendo binari sincopati e interminabili percorsi a piedi tra pianure boschi e paludi di Polonia e Bielorussia Levi aveva seguito il percorso casuale e caotico dell’Armata Rossa in smobilitazione, epico organismo multicefalo governato solo dall’ordine supremo di rientro e dalla voglia infinita di tornare nelle proprie case, in treno, a cavallo, a piedi o su taxi e pulmann saccheggiati nella Germania nazista.
Primo Levi racconta, in un intervista, che uno dei suoi più grandi rimpianti fu quello di non aver viaggiato. Dopo tutto quello che gli era successo c’erano così tante cose da fare: il matrimonio, la famiglia da mantenere, il lavoro di chimico, la fabbrica da dirigere, i figli da mandare a scuola, la vita normale insomma. Per la fabbrica di vernici andò in Germania e in Russia, a risolvere i problemi dei clienti, ma non era esattamente quello che intendeva per viaggiare. C’era stato un periodo della sua vita, così piacevolmente lontano da qualsiasi concetto di viaggio organizzato, che ricordava sempre con piacere, che riempiva le serate con gli amici e poteva raccontare senza timore di rattristare o disgustare i suoi ascoltatori. Subito dopo essere stato liberato dalla prigionia Levi fu infatti sballottato lungo tutta l’Europa dell’Est per mesi, senza una meta o un posto definitivo dove fermarsi che non fosse un Italia vagheggiata e lontana come l’Itaca di Ulisse. Seguendo binari sincopati e interminabili percorsi a piedi tra pianure boschi e paludi di Polonia e Bielorussia Levi aveva seguito il percorso casuale e caotico dell’Armata Rossa in smobilitazione, epico organismo multicefalo governato solo dall’ordine supremo di rientro e dalla voglia infinita di tornare nelle proprie case, in treno, a cavallo, a piedi o su taxi e pulmann saccheggiati nella Germania nazista.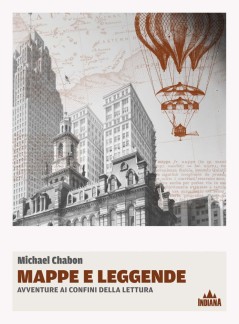 La nostra contemporaneità intellettuale, il nostro insegnamento universitario, saggi e libri di critica sulla storia della letteratura ci raccontano a lungo e con gusto del postmoderno e delle sue varie componenti alchemiche: l’ironia, la scomparsa dei generi o la loro ibridazione, la metaletteratura e i piani di lettura. I numi tutelari di Borges e Calvino ci guidano, il loro nome scritto su un foglietto e inserito nella bocca di argilla. Poi però, a guardarsi intorno, sembra che girino tutti a caso. La biblioteca immaginaria e la mappa dell’imperatore sono metafore utilissime quando si parla di Amazon o Maps, e Italo avrà detto sicuramente qualcosa di intelligente su questo o quell’argomento quando serve. Nella mia infinita pigrizia e arroganza posso tranquillamente affermare di aver conosciuto questi due grandi autori da lontano, in modo distratto e superficiale, ma ho l’impressione di essere in buona compagnia. C’è chi dice che il romanzo è morto, chi che non ha mai vissuto, che la trama è inutile, che comunque sono meglio le serie televisive, chi dà la colpa a Checco Zalone (ma non faceva cinema?) e che è tutto uno schifo ma alla fine scriveranno tutti racconti perché si adattano meglio alla nostra società. Lo ribadisco. Sono pigro e distratto da praticamente qualsiasi cosa che mi venga agitata sotto al naso, ma francamente non ci capisco niente. Da qui il tentativo di approfondire la faccenda in modo autonomo, leggendo più cose che spieghino la materia di cui sono fatti i libri.
La nostra contemporaneità intellettuale, il nostro insegnamento universitario, saggi e libri di critica sulla storia della letteratura ci raccontano a lungo e con gusto del postmoderno e delle sue varie componenti alchemiche: l’ironia, la scomparsa dei generi o la loro ibridazione, la metaletteratura e i piani di lettura. I numi tutelari di Borges e Calvino ci guidano, il loro nome scritto su un foglietto e inserito nella bocca di argilla. Poi però, a guardarsi intorno, sembra che girino tutti a caso. La biblioteca immaginaria e la mappa dell’imperatore sono metafore utilissime quando si parla di Amazon o Maps, e Italo avrà detto sicuramente qualcosa di intelligente su questo o quell’argomento quando serve. Nella mia infinita pigrizia e arroganza posso tranquillamente affermare di aver conosciuto questi due grandi autori da lontano, in modo distratto e superficiale, ma ho l’impressione di essere in buona compagnia. C’è chi dice che il romanzo è morto, chi che non ha mai vissuto, che la trama è inutile, che comunque sono meglio le serie televisive, chi dà la colpa a Checco Zalone (ma non faceva cinema?) e che è tutto uno schifo ma alla fine scriveranno tutti racconti perché si adattano meglio alla nostra società. Lo ribadisco. Sono pigro e distratto da praticamente qualsiasi cosa che mi venga agitata sotto al naso, ma francamente non ci capisco niente. Da qui il tentativo di approfondire la faccenda in modo autonomo, leggendo più cose che spieghino la materia di cui sono fatti i libri.














