 Primo Levi racconta, in un intervista, che uno dei suoi più grandi rimpianti fu quello di non aver viaggiato. Dopo tutto quello che gli era successo c’erano così tante cose da fare: il matrimonio, la famiglia da mantenere, il lavoro di chimico, la fabbrica da dirigere, i figli da mandare a scuola, la vita normale insomma. Per la fabbrica di vernici andò in Germania e in Russia, a risolvere i problemi dei clienti, ma non era esattamente quello che intendeva per viaggiare. C’era stato un periodo della sua vita, così piacevolmente lontano da qualsiasi concetto di viaggio organizzato, che ricordava sempre con piacere, che riempiva le serate con gli amici e poteva raccontare senza timore di rattristare o disgustare i suoi ascoltatori. Subito dopo essere stato liberato dalla prigionia Levi fu infatti sballottato lungo tutta l’Europa dell’Est per mesi, senza una meta o un posto definitivo dove fermarsi che non fosse un Italia vagheggiata e lontana come l’Itaca di Ulisse. Seguendo binari sincopati e interminabili percorsi a piedi tra pianure boschi e paludi di Polonia e Bielorussia Levi aveva seguito il percorso casuale e caotico dell’Armata Rossa in smobilitazione, epico organismo multicefalo governato solo dall’ordine supremo di rientro e dalla voglia infinita di tornare nelle proprie case, in treno, a cavallo, a piedi o su taxi e pulmann saccheggiati nella Germania nazista.
Primo Levi racconta, in un intervista, che uno dei suoi più grandi rimpianti fu quello di non aver viaggiato. Dopo tutto quello che gli era successo c’erano così tante cose da fare: il matrimonio, la famiglia da mantenere, il lavoro di chimico, la fabbrica da dirigere, i figli da mandare a scuola, la vita normale insomma. Per la fabbrica di vernici andò in Germania e in Russia, a risolvere i problemi dei clienti, ma non era esattamente quello che intendeva per viaggiare. C’era stato un periodo della sua vita, così piacevolmente lontano da qualsiasi concetto di viaggio organizzato, che ricordava sempre con piacere, che riempiva le serate con gli amici e poteva raccontare senza timore di rattristare o disgustare i suoi ascoltatori. Subito dopo essere stato liberato dalla prigionia Levi fu infatti sballottato lungo tutta l’Europa dell’Est per mesi, senza una meta o un posto definitivo dove fermarsi che non fosse un Italia vagheggiata e lontana come l’Itaca di Ulisse. Seguendo binari sincopati e interminabili percorsi a piedi tra pianure boschi e paludi di Polonia e Bielorussia Levi aveva seguito il percorso casuale e caotico dell’Armata Rossa in smobilitazione, epico organismo multicefalo governato solo dall’ordine supremo di rientro e dalla voglia infinita di tornare nelle proprie case, in treno, a cavallo, a piedi o su taxi e pulmann saccheggiati nella Germania nazista.
Di questo viaggio picaresco Primo Levi ci riporta i luoghi e gli stati d’animo che lo accompagnavano, ma soprattutto le persone incontrate. Personaggi e avventure raccontate con l’esperienza del narratore navigato, che ha raffinato il suo eloquio smussando gli angoli ed esaltando le tinte dei suoi racconti davanti a platee di ragazzini delle medie e durante serate tra amici, prima di pubblicare La tregua. Sono racconti. Tristi allegri o semplicemente notabili, ma in cui non viene mai meno l’esigenza profonda di ogni racconto: riferire lo straordinario e quanto di anomalo o inaspettato può succedere nella vita. Curioso, e fatalmente incompreso dai suoi compagni di viaggio, lo scrittore annota e registra nella sua memoria visi, lingue sconosciute e paesaggi immensi. Un mondo sparito, e non solo a causa dei rivolgimenti della guerra, della caduta degli imperi, della fuga degli ebrei aschenaziti in Israele o per la Guerra Fredda. È un limbo fragile, che durerà finché Russia e USA non si saranno spartiti l’Europa in rovina, le improvvisate famiglie di guerra dovranno decidere in che paese vivere e tutti i rifugiati saranno tornati alle loro case. Circondato da prigionieri, profughi, soldati e cittadini multilingui, Levi vive in un Europa così mescolata e imprecisa, senza cartelli e confini stabili, multiforme ibrida e promiscua. In questa Babele tutti si capiscono, parlando il linguaggio del commercio, quello dell’Amore, la mimica teatrale, il latino oppure il tedesco. A volte se si ha fortuna anche in italiano. Prigionieri, nemici e alleati sono mescolati in un calderone irrazionale fatto di sesso occasionale, borsa nera e burocrazia folle, campi profughi allestiti in mezzo alla foresta, mandrie di cavalli saccheggiate per settimane e zingari che si muovono su carri grandi come case.
In questo mondo fragile i personaggi di Levi sono vivi, memorabili, ma non per una loro reale esistenza in qualche punto dello spazio tempo, ma per il soffio che l’autore ha saputo instillare nelle parole che ce li descrivono. Dantesco il Moro di Verona, vecchio e roccioso muratore, instancabile lavoratore e bestemmiatore raffinato, scuro di pelle e bianco di pelo, Caronte senza traghetto. Ancora più antichi e primordiali gli amici faccendieri, il romano Cesare e il greco Mordo Nahum, fratello volpe e fratello lupo, che fanno della sopravvivenza un’arte. I russi, chiassosi e ubriachi, forti e felici, vittoriosi e idealisti, un unico personaggio che si invera in singole sostanze con cui litigare, da cui ricevere ordini, di cui innamorarsi, da ammirare e da comprendere. Levi si scontra e si incontra con il ridicolo e con la tragedia.Vive.
Ma questa è una pausa, un limbo,un sogno, una tregua, che Levi ricorda e rimpiange. Prima di tornare a casa, prima di ricominciare la vita normale. L’incubo è finito, ma nulla impedisce ora al sogno di terminare, come è già terminato una volta. Per lasciare il posto al terribile risveglio. Un libro pieno di vita, di cose fatte, viste e annusate, toccate, ricordate e ascoltate, vissute e sognate, si apre e si chiude con immagini di morte e di orrore. La realtà dei compagni morenti e morti, il piccolo Hurbinek senza lingua, figlio del campo di concentramento, l’incubo che torna a tormentare la pace, il capo chino per terra a cercare qualcosa da mangiare o da scambiare. Un odio verso i tedeschi e la loro ottusa obbedienza che Levi fatica a trattenere, se non poi provare altro che pena nel vederli abbruttiti e affamati che si aggirano tra le macerie della loro Patria. La paura che nessuno creda, che nessuno voglia ascoltare. Che il sogno finisca di nuovo. L’ombra non ha vinto, certo, e Levi ha vissuto ed è stato molto felice, ma come un pugnale maledetto Auschwitz gli ha lasciato una ferita che lo tormenta ad ogni anniversario. Luce e ombra. Le due cose vanno assieme, dice Levi, con le sue facce sorridenti nelle foto in bianco e nero: attorno a una stella c’è sempre tanto buio.








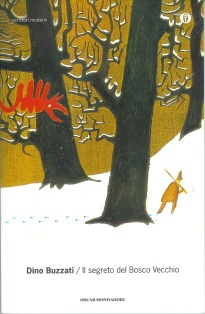
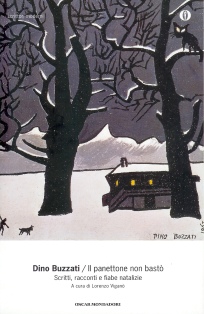
 Nel resto dell’articolo citato qui sopra non troverete le seguenti espressioni: tragedia annunciata, tragedia nella tragedia, rabbia e dolore, l’Europa si muova, Bossi-Fini, ministro Kyenge, reato di clandestinità. Non so se sia effettivamente cambiato qualcosa nel modo di fare giornalismo. So solo che Lampedusa per me resta un’espressione puramente geografica e trecentocinquanta è sempre la cifra che segue trecentoquarantanove. E’ solo colpa mia, che sono cinico? Una volta, tanto tempo fa, avevo provato a scrivere delle cose per un giornale locale: «Solo i fatti, solo ed esclusivamente i fatti, niente opinioni». Non che sia sbagliato certo, bisogna essere obbiettivi, avvicinarsi il più possibile alla verità dei fatti. E nessuno scrive più elzeviri, nessuno scrive più un articolo come quello sopra, sembra che bastino le parole tragedia e lutto, orrore e dolore per descrivere la morte. Chi potrebbe scrivere “pazzescamente affascinati”?
Nel resto dell’articolo citato qui sopra non troverete le seguenti espressioni: tragedia annunciata, tragedia nella tragedia, rabbia e dolore, l’Europa si muova, Bossi-Fini, ministro Kyenge, reato di clandestinità. Non so se sia effettivamente cambiato qualcosa nel modo di fare giornalismo. So solo che Lampedusa per me resta un’espressione puramente geografica e trecentocinquanta è sempre la cifra che segue trecentoquarantanove. E’ solo colpa mia, che sono cinico? Una volta, tanto tempo fa, avevo provato a scrivere delle cose per un giornale locale: «Solo i fatti, solo ed esclusivamente i fatti, niente opinioni». Non che sia sbagliato certo, bisogna essere obbiettivi, avvicinarsi il più possibile alla verità dei fatti. E nessuno scrive più elzeviri, nessuno scrive più un articolo come quello sopra, sembra che bastino le parole tragedia e lutto, orrore e dolore per descrivere la morte. Chi potrebbe scrivere “pazzescamente affascinati”? Ci sono libri che, una volta venuti alla luce, si depositano silenziosi sugli scaffali delle biblioteche o sulle mensole di qualche possessore di libri particolarmente stramboide. Al buio. Una breve esistenza negli scaffali delle novità e poi basta, nessuna ristampa, nessun seguito. Il nulla. Un fallimento editoriale. Dobbiamo dispiacerci forse per il loro destino d’oblio? E rimproverare la casa editrice o l’addetto al marketing di aver permesso al libro di scomparire? Era un libro brutto? È possibile invece che per qualche misterioso motivo i libri accecati dalla luce troppo sfolgorante della ribalta decidano motu proprio di ritirarsi dalla vista. Piano piano, anno dopo anno, secolo dopo secolo, questi libri non si trovano più sulle liste, le loro pagine web diventano obsolete, scivolano piano piano grazie alle mani di un’inconsapevole commesso dallo scaffale delle novità a quello di un genere che non è il loro, al magazzino, al macero. È timidezza? O speranza di una gloria più grande in futuro? Forse attendono con trepidazione che un archeologo librario entri nel loro antro polveroso e li renda grandi, più grandi di quanto avessero sperato.
Ci sono libri che, una volta venuti alla luce, si depositano silenziosi sugli scaffali delle biblioteche o sulle mensole di qualche possessore di libri particolarmente stramboide. Al buio. Una breve esistenza negli scaffali delle novità e poi basta, nessuna ristampa, nessun seguito. Il nulla. Un fallimento editoriale. Dobbiamo dispiacerci forse per il loro destino d’oblio? E rimproverare la casa editrice o l’addetto al marketing di aver permesso al libro di scomparire? Era un libro brutto? È possibile invece che per qualche misterioso motivo i libri accecati dalla luce troppo sfolgorante della ribalta decidano motu proprio di ritirarsi dalla vista. Piano piano, anno dopo anno, secolo dopo secolo, questi libri non si trovano più sulle liste, le loro pagine web diventano obsolete, scivolano piano piano grazie alle mani di un’inconsapevole commesso dallo scaffale delle novità a quello di un genere che non è il loro, al magazzino, al macero. È timidezza? O speranza di una gloria più grande in futuro? Forse attendono con trepidazione che un archeologo librario entri nel loro antro polveroso e li renda grandi, più grandi di quanto avessero sperato.












